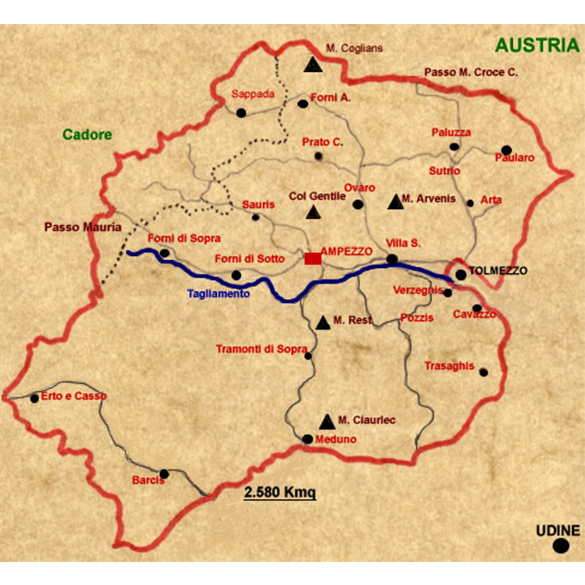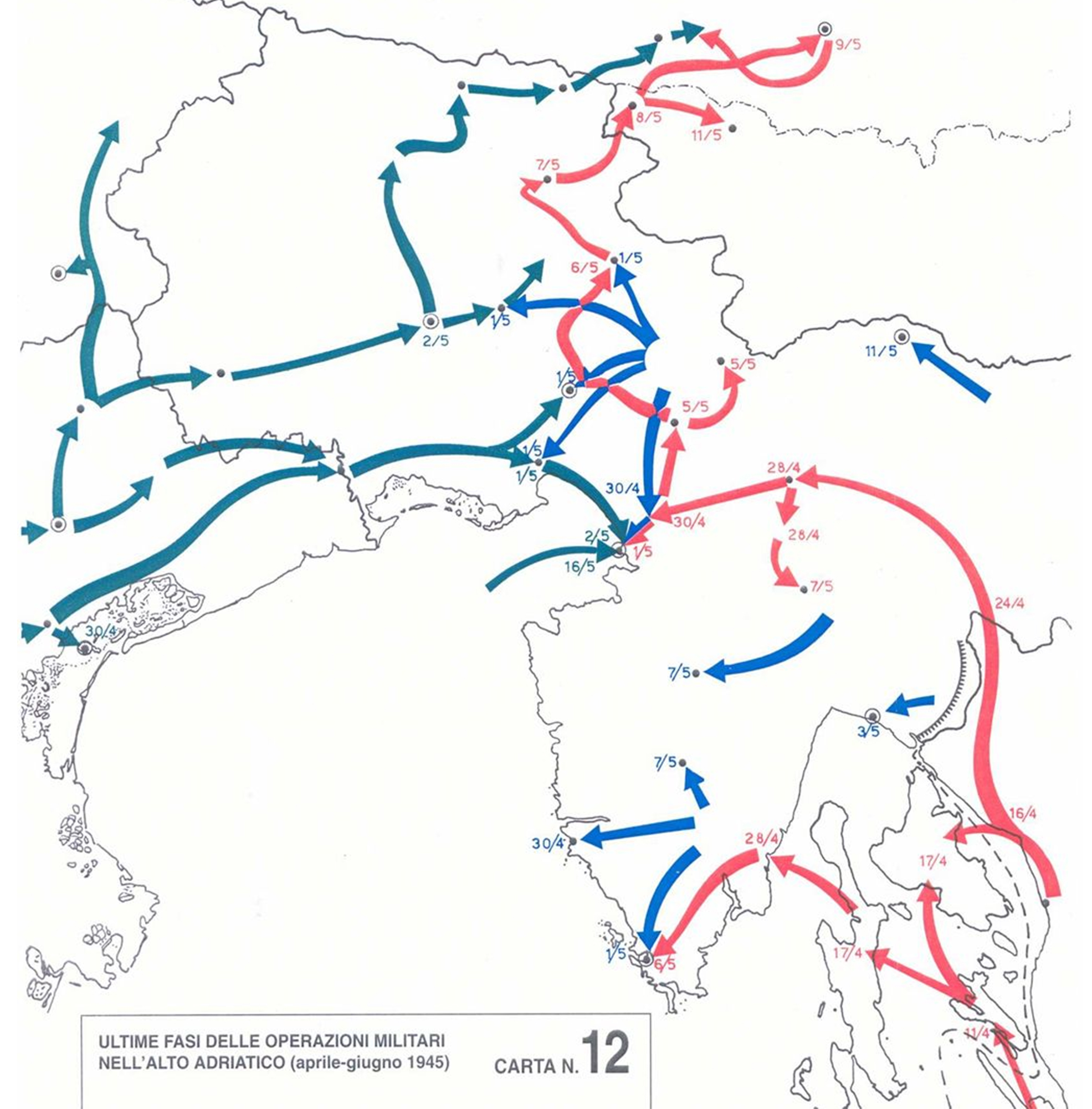Bonifica etnica fascista

Bonifica etnica fascista
Novecento
Scarica il PDF
Video: I fucilati di Basovizza
di Anna Vinci
Una delle fonti principali d’ispirazione del fascismo di confine è senz’altro rappresentata dal nazionalismo e dall’irredentismo reinventato interamente in chiave nazionalista: il tema dell’antislavismo si annida quindi nel cuore del nuovo movimento e poi del PNF, sia pur con gradazioni diverse via via che ci si allontana dal centro triestino verso il Friuli occidentale. In ogni modo l’antislavismo è un tratto caratterizzante valido per tutto il territorio giuliano e friulano, non disgiunto dall’antisocialismo e dall’anticomunismo: tant’è che l’accusa principale che si costruisce contro gli oppositori è spesso sintetizzata dalla formula dello “slavo- comunismo”.
Lo stato fascista assume, sotto il suo controllo, la violenza esercitata dalle squadre e nello stesso tempo mette in atto una serie di provvedimenti legislativi tendenti sia ad escludere la popolazione slovena e croata della regione dalla vita pubblica sia ad oscurarne in toto l’esistenza. Nel 1934, l’edizione della Guida d’Italia del Touring Club Italiano decreta l’assoluta nullità di quella presenza, etichettata come non autoctona. “L’allogeno che non c’è”, diventa uno dei leit-motiv della propaganda fascista e di altre fonti scientifico/divulgative, ben uniformate alla linea che il regime sta seguendo.
Il processo di assimilazione degli sloveni e dei croati assume un’accelerazione nei primi anni Venti. Similmente a quanto accade nell’Alto Adige, anch’esso facente parte delle cosiddette Nuove Province, il fascismo avvia una serie di provvedimenti legislativi per l’italianizzazione della popolazione slovena e croata, tentando innanzitutto di estromettere dagli uffici pubblici quei funzionari che non avessero ottenuto la cittadinanza italiana, sulla base del diritto di opzione previsto dai Trattati di pace: tale diritto – affidato al vaglio di apposite Commissioni che prolungano il loro lavoro oltre la data della loro costituzione, avvenuta alla fine del 1920 – viene interpretato dal fascismo in modo via via più restrittivo – tanto è vero che nel 1923, a seguito di altre indicazioni intransigenti da parte di Mussolini, il prefetto della Venezia Giulia Crispo Moncada chiede di non riconfermare sei funzionari – ma si propone come ancor più drastico censore verso tutti quegli impiegati e funzionari (italiani e sloveni) che fossero stati in servizio ai tempi dell’Impero e cioè prima della Grande guerra. Lo zelo persecutorio delle istituzioni periferiche supera in molti casi le dure scelte del centro. Crispo Moncada si distingue in particolare nel contrasto serrato contro il clero sloveno e croato e in una dura contesa con il vescovo mons. Bartolomasi, sfidando le stesse raccomandazioni della S. Sede. Agli inizi del 1923, mons. Bartolomasi è di fatto costretto a lasciare la sede episcopale triestina. La subitanea persecuzione del clero «slavo» mira non solo ad abbattere quella che è considerata una guida essenziale delle popolazioni slovene e croate nelle campagne e nella stessa città, ma anche ad impedire che il mantenimento della madre lingua in alcune funzioni religiose, sia di ostacolo al progetto di piena italianizzazione dell’area. In tal modo una parte importante del ceto dirigente di quelle comunità viene disperso: vi contribuisce non poco l’atteggiamento ondeggiante della S. Sede. Con la firma dei Patti lateranensi nel 1929 che sanciscono la priorità assoluta dell’alleanza Chiesa – fascismo, rispetto a tutte le altre esigenze, cade ogni speranza. Vengono rimossi quei vescovi (mons. Sedej da Gorizia, nel 1931, e mons. Fogar da Trieste, nel 1936) che con maggiore attenzione avevano tentato di mantenere un legame forte con tutto il loro popolo di credenti e avevano contrastato le scelte governative. La Chiesa, ormai, decide di configurarsi come “Chiesa nazionale”, sacrificando energie e minando alla radice la sua stessa comunità di fedeli.
Nello stesso anno della prima emanazione del complesso delle leggi della riforma scolastica gentiliana, un decreto legge (R.D. 27 aprile 1923) cancella toponomastica slovena, croata e tedesca della regione, affidando la conservazione dei nomi della consuetudine (e degli affetti) all’uso orale.
La riforma scolastica gentiliana che vede la luce attraverso un complesso di leggi emanate tra il 1923 e il 1924, con il suo impianto organico ed elitario (più volte rimaneggiato poi negli anni successivi), muove “dal concetto integrale dello Stato nazionale ed ha come fine supremo la Nazione”. In questa prospettiva è con lucida determinazione che lo stesso Gentile, risponde alle proteste contro la riforma dei deputati sloveni ancora presenti in Parlamento: “L’Italia vuole dei cittadini che parlino la lingua dello Stato, e con legittimo orgoglio ricordo è […] che la cultura italiana è stata in ogni tempo faro di civiltà e onore e vanto del nostro popolo”.
“Alle lingue d’uso locali”, Gentile promette uno spazio di ore aggiuntive. La tensione nazionalistica che aveva accompagnato fin dalla fine della guerra il problema della rinascita e del possibile ampliamento del sistema scolastico di lingua slovena e croata (né vanno tuttavia dimenticate nemmeno le scuole primarie di lingua tedesca che funzionavano ancora nelle terre al confine nord – orientale), si risolve con un intervento che raggiunge d’un balzo una meta agognata, impensabile prima dell’avvento al governo del fascismo. Nel 1925 viene approvato un decreto legge che consente solo l’uso della lingua italiana nelle scuole, eliminando così qualsiasi forma di gradualità prevista inizialmente. Il governo della dittatura chiude entro l’anno 1930 – 1931 anche le ultime scuole private non italiane ancora esistenti. La rete delle scuole slovene e croate è così completamente smantellata: dalla storiografia slovena sono stimate, ad esempio, a 488 le scuole elementari chiuse, con un conteggio che parte dal 1918 fino al 1928; dal 1928 al 1943 vengono intanto trasferiti all’interno del Regno circa 400 insegnanti “allogeni”.
È tuttavia nel gioco tra centro e periferia, tra Stato e PNF che la “scuola di confine” si definisce concretamente: lo Stato che si avvia alla fascistizzazione, trova un sostegno poderoso negli stimoli locali. Per l’allontanamento dei maestri sloveni e croati, ad esempio, chi pretende maggior decisione è tanto il provveditore agli studi, Reina (che ha la competenza estesa alla Venezia Giulia, a Zara e al Friuli), quanto l’Associazione nazionale fascista degli insegnanti. Il provveditore sollecita licenziamenti già nella primavera del 1924 per comportamenti antinazionali e deve frenarsi sulla base dei richiami di Giuseppe Lombardo Radice, allora collaboratore di Gentile al Ministero, attento a richiedere “rigorosi accertamenti”. Ma è la legge approvata 24 dicembre 1925 sulla dispensa dei pubblici funzionari giudicati politicamente inaffidabili a consentire il giro di vite più rilevante. Il provveditore ben interpreta il clima. Sono fitte le segnalazioni sui maestri “infidi” (dalla MVSN, dagli ispettori scolastici, dalle sottoprefetture) e tutto il lavorio di osservazione sui maestri e sulle associazioni slovene e croate degli insegnanti richiede un continuo aggiornamento.
Un problema grave è quello della tenuta della rete scolastica, che non solo ha il compito di rintuzzare il fenomeno dell’analfabetismo (molto forte soprattutto nella regione istriana) ma anche quello di veicolare il messaggio fascista in una zona di confine. E vi è di certo il timore che lo scontento dei maestri allontanati possa alimentare le correnti già attive del fuoriuscitismo. È allora rilevante l’insistenza che i funzionari sul territorio pongono sul fatto che non è tanto l’amore verso la “grande Madre” ciò che è richiesto a figure di snodo come quelle dei maestri: la conversione all’italianità è ritenuta impossibile da parte “dell’elemento slavo”. Deve subentrare piuttosto, al posto delle vecchie forme di lealtà, l’adesione allo Stato nuovo: l’esempio della milizia allogena è, in tal senso, importante.
Nel 1927, la possibilità di trasferire nelle altre regioni d’Italia i maestri per cui non sussistano motivi sufficienti per il licenziamento, incide ancora più pesantemente sul terreno dell’educazione delle giovani generazioni. Una scuola primaria in cui è negato l’uso della lingua materna definisce una frattura profonda rispetto alle famiglie e alle generazioni più anziane. Il provveditore, che ha una grande discrezionalità nel condurre in porto l’operazione (il trasferimento e il licenziamento dei maestri sono sostanzialmente nelle sue mani), mostra uno zelo pari alla sua preoccupazione di ben figurare di fronte all’autorità centrale: si tratta del resto di una figura professionale in prepotente ascesa, proprio grazie alla riforma Gentile.
Uno dei maggiori assilli delle autorità periferiche è in ogni caso anche quello di ottenere personale adatto, vuoi per coprire i posti resi vacanti “nella scuola di confine” per i trasferimenti e per gli allontanamenti dei maestri (e poi per gli arresti e la designazione al confino di molti di essi), vuoi per l’istituzione di nuovi uffici che le funzioni stesse dello Stato fascista rendono necessari nell’area orientale.
Il R.d.l. del 10 gennaio 1926, predisposto inizialmente “a beneficio” delle famiglie di Trento, viene esteso, su sollecitazione del prefetto di Trieste, e a tutti i territori annessi. Esso prevede che si debbano “restituire” i cognomi in forma italiana, ma che la loro “riduzione” (e riscrittura) in italiano sia facoltativa: in realtà è questo un piccolo esempio che aiuta a capire come agiscano in accordo le organizzazioni fasciste e gli apparati dello Stato. Le autorità istituzionali, attraverso una Commissione ad hoc provvedono alla “restituzione di fatto e d’autorità” ed esplicitamente si affidano invece al PNF per “la riduzione” (ed il ricatto verso gli incerti o i ribelli). Il provvedimento entra nella sfera della dignità personale sconvolgendo il senso di appartenenza e di identità dei singoli e delle famiglie, mentre la rete delle parentele non sempre può usufruire della stessa forma di “riduzione” dei cognomi.
Il rimbalzo in sede locale delle legge sulla disciplina delle associazioni approvata in Parlamento il 26 novembre 1925, un anno prima della promulgazioni delle leggi “fascistissime”, riguarda inevitabilmente tutto il ricco tessuto associativo delle opposizioni politiche e, a ondate successive, l’abbattimento delle case editrici (7 nella sola Gorizia), e delle tipografie, lo scioglimento dei circoli e delle associazione culturali, assistenziali, ricreative, sportive, di mutuo soccorso del mondo sloveno e croato. Certo la dittatura è dittatura per tutti e le leggi liberticide del 1926 (con l’effettiva soppressione della libera stampa, il riconoscimento del PNF come partito unico della Nazione etc..) valgono per ogni angolo d’Italia, ma la cancellazione della libertà di stampa e il tracollo della pubblicazione di libri e opuscoli in lingua slovena e croata, compromette in modo serio la forza vitale di quella comunità. Molto giustamente osserva un opuscolo pubblicato da “Giustizia e Libertà” nel 1933: agli “allogeni” è toccato un “flagello soprannumerario” che è quello di dover parlare “pensare e sognare solamente nella lingua […] dei dominatori”.
Le liste delle società sono già pronte, per opera della MVSN, dei carabinieri, della questura. Le formule codificate della schedatura sono dettate dalle regole del sospetto. Lo spettro di una minaccia “irredentista” manovrata dall’esterno, è continuamente agitata; si valica così senza difficoltà il confine tra la presunzione del reato contro l’ordine pubblico e la colpevolezza giudizialmente accertata. Infine, la liquidazione del tessuto cooperativo e creditizio sloveno e croato, già in prepotente ascesa in epoca asburgica, frena bruscamente le vive speranze di affermazione del ceto medio di quelle nazionalità. Si tratta tuttavia di un’operazione che non può essere condotta se non con grande cautela, nonostante il battage propagandistico e a dispetto di tutte le informazioni raccolte intorno agli strettissimi legami tra quel sistema creditizio e le banche dello Stato RHS (soprattutto della Slovenia e della Croazia). Dietro le casse rurali si riconoscono, ad esempio, molto chiaramente le organizzazioni politiche liberali e cattoliche, ma toccare gli organismi di credito significava mettere in pericolo l’intera rete del risparmio e una somma d’interessi che si dilatava ben al di là dei confini posti tra nazionalità diverse. In tal modo, per fare l’esempio dell’area istriana, la riorganizzazione delle Casse rurali si estende ben oltre il 1927, nonostante lo scioglimento di molti consigli d’amministrazione degli istituti “allogeni”. Già agli inizi degli anni Trenta, tuttavia, la ricostituzione dell’Ente per la rinascita agraria delle Tre Venezie punta ad un progetto di esproprio delle proprietà terriere “in possesso di allogeni” per insediare famiglie italiane, ottenendo alcuni risultati di un certo rilievo.
La borghesia slovena e croata della Venezia Giulia (o quello che ne era rimasto, dopo i molti provvedimenti di espulsione e le molte fughe avvenute a partire dalla fine della guerra) viene drasticamente ridimensionata e di fatto largamente sostituita, negli uffici pubblici e nelle professioni, da homines novi di provata fede fascista e italiana. Spariscono professionalità e presenze significative, danneggiando non solo la crescita di un ceto medio sloveno e croato, ma lo stesso tessuto sociale della regione e la ricchezza della sua articolazione. Le sostituzioni con personale italiano sono troppo spesso problematiche e precarie. Viene da chiedersi quanto lo sviluppo e i processi di modernizzazione innescati tra le due guerre nell’area orientale siano stati compromessi da tali scelte politiche di esclusione.
Nel novembre del 1926, il provveditore di Trieste segnala 746 studenti sloveni iscritti agli istituti medi: essi si dichiarano, all’atto dell’iscrizione, di nazionalità italiana, mostrando così – secondo la massima autorità scolastica regionale – la volontà di puntare ad una formazione che li integri nella classe dirigente nazionale. Sembra, dal suo punto di vista, un buon risultato raggiunto, nella direzione della cancellazione di ogni diversità, e quasi un segno di ravvedimento delle famiglie. È tuttavia un giudizio che non tiene conto di scelte che molte famiglie si sentono di fatto costrette a compiere. Tra l’altro, molti ragazzi sloveni e croati vanno a studiare in Jugoslavia (Lubiana o Zagabria), sollecitati da borse di studio e premi concessi da istituzioni private o pubbliche del vicino Stato; le misure di restrizione relative al rilascio dei passaporti, anche solo per motivi di studio, cominciano tuttavia a funzionare già nell’estate del 1926.
Intanto, si mette in gioco la sfera del privato, in modo senz’altro più invasivo di quanto avviene per la popolazione italiana, per i molti sloveni e croati che restano nell’area al confine orientale, sia per il suono negato dei nomi e cognomi nella propria lingua sia per lo strappo imposto, sul terreno dell’educazione, tra vecchie e giovani generazioni. I provvedimenti sono spesso inefficaci e controproducenti, ma non per questo meno feroci.
Il regime fascista adotta inoltre in queste terre provvedimenti di polizia indubbiamente molto più numerosi e drastici rispetto al resto d’Italia. Un’organizzazione sempre più efficiente delle forze di polizia (tra esse, l’OVRA e la Polizia politica) porta alla luce un antifascismo dalle molte articolazioni (italiano, sloveno e croato, di matrice nazionale e/o legato alla tradizione operaia e al mondo comunista). L’organizzazione della polizia fascista si perfeziona in questi anni, creando una struttura forte che dà grande prova di sé proprio nell’area al confine orientale, soprattutto a partire dagli anni Trenta e fino alle soglie della II guerra mondiale. La sorveglianza sempre più intrusiva, con l’uso frequente delle delazioni, porta al deferimento di un numero consistente di persone presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito nel 1926. La legislazione che è adottata a metà degli anni Venti consente sanzioni pesanti come il confino e il carcere, fino alla pena di morte per quanti sono accusati di complottare o agire contro il regime. Per fare solo un esempio, dal 1926 all’inizio della guerra, vengono deferiti al Tribunale speciale 819 residenti e 902 nati in Friuli (denominazione in uso nei conteggi statistici), senza contare tutti gli altri provvedimenti di polizia contro antifascisti, sloveni, croati e comunisti (4625 tra i residenti).
Di fronte a quello che è stato definito “genocidio culturale” di un intero popolo, la risposta in molti casi è quella della clandestinità: è intensa la circolazione di opuscoli e libri in lingua slovena mentre l’attività di larga parte del clero sloveno e croato punta alle scuole parrocchiali, alla musica e al canto corale nella lingua materna avviando la committenza (in particolare per l’artista Tone Kralj) per affrescare alcune chiese con chiare allusioni nazionali e di opposizione al fascismo.
Nasce alla fine degli anni Venti, un nucleo clandestino denominato TIGR (acronimo di: Trieste, Istria, Gorizia Rijeka/Fiume) che, sull’esempio del movimento nazionalista irlandese promuove – in collegamento con le organizzazioni irredentiste e terroriste jugoslave tra cui l’Orjuna particolarmente forte in Slovenia – interventi propagandistici, accompagnati da atti intimidatori e terroristici anche per colpire coloro che, tra la popolazione slovena e croata, dimostrassero atteggiamenti filofascisti. Ben vista in una prima fase da esponenti italiani dalla Concentrazione antifascista, è invece osteggiata dal Pcd’I fino al 1934 quando la politica del Fronte popolare apre ad una più vasta collaborazione, in cui sono inclusi i movimenti più marcatamente irredentisti e nazionalisti.
In seguito ad un’azione contro il “Popolo di Trieste”, con la conseguente morte di un redattore, la cellula del TIGR operante a Trieste, denominata Borba, viene portata alla luce. Nel settembre 1930, di fronte al Tribunale speciale, per l’occasione trasferitosi a Trieste, sono condannati a morte dopo una rapidissima istruttoria quattro imputati, fucilati nel giro di pochissimo tempo a Basovizza; vi sono poi cinque condannati a 15 anni di carcere, a fronte di 14 incriminati. Un anno prima, a Pola, era stato condannato a morte, dallo stesso Tribunale speciale, un altro oppositore croato, mentre altri quattro suoi compagni furono condannati a molti anni di carcere. La rete clandestina del TIGR, colpita duramente da tali provvedimenti, era in realtà molto estesa nelle zone indicate dalla sua stessa sigla e quindi difficilmente estirpabile.
La propaganda e il disprezzo verso la popolazione slovena e croata, relegata alla categoria degli “infedeli” si unisce spesso a forme di allettamento soprattutto sul piano dell’assistenza verso i più disagiati. Il totalitarismo fascista, puntando alla ridefinizione del corpo nazionale sotto le sue esclusive insegne, segue, infatti, molte strade, con risultati spesso favorevoli: l’adescamento (e la «conversione») «dei diversi» è una di queste. Valga, come esempio, il caso del sistema di welfare adottato dalla dittatura (dalla creazione dell’ONMI all’istituzione dei Consorzi antitubercolari, alla distribuzione di minimi aiuti ai miseri, italiani ma anche sloveni e croati): erano già state distrutte le istituzioni messe in campo dal socialismo giuliano prima della Grande guerra, ispirate a moderne concezioni di sostegno per i più deboli e volte a miglioramenti progressivi. L’estensione dell’assistenza fascista nelle campagne, la propaganda che accompagnava ogni singola azione di soccorso, metteva tuttavia in ombra le molte pecche della nuova organizzazione, in grado così di essere accolta favorevolmente dai più disagiati.
Che l’operazione di “bonifica etnica” sia riuscita non si può dire, poiché la popolazione, nelle chiese e nelle case, continuava in buona misura a preservare la propria identità, in campo aperto o in modo silente. “Brutale e fiacca” è stata definita quella scelta di snazionalizzazione tanto esaltata dalla propaganda: un censimento riservato del 1939 per tutta la Venezia Giulia, impostato secondo i criteri della lingua d’uso, mostra alle autorità competenti la solidità della presenza “allogena”, ben poco intaccata, rispetto al 1921, nella sua consistenza numerica (circa 395.000 alloglotti presenti su una popolazione di un 1.000.000 unità), nonostante il profluvio delle disposizioni persecutorie e l’importante fuoriuscitismo.
Bibliografia essenziale
Apih E., Italia, Fascismo e Antifascismo nella Venezia Giulia, 1918/1943, Laterza, Bari 1966.
Di Michele A., L’italianizzazione imperfetta. L’italianizzazione dell’amministrazione pubblica dell’Alto Adige tra Italia liberale e fascismo, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2003.
Kacin Wohinz M., Jože Pirjevec J., Storia degli sloveni in Italia 1866-1998, Marsilio, Venezia 1998.
Wörsdörfer R., Il confine orientale. Italia e Jugoslavia dal 1915 al 1955, Il Mulino, Bologna 2009.